Pier Paolo Pasolini intervistato dalla rivista «Arts in society», 1966-67. Le domande sono state elaborate dagli studenti del corso di Storia e Teoria del Cinema dell’University of Wisconsin.
- Città Pasolini

- 1 giorno fa
- Tempo di lettura: 7 min

Io, Paolo Pasolini (Roma), ho descritto il mondo dei poveri, e più precisamente il sottoproletariato romano e meridionale, nei film Accattone (1961), Mamma Roma (1962) e Il Vangelo secondo Matteo (1964). Tuttavia — sebbene in modo contraddittorio — ho esaminato questa “civiltà della povertà italiana” alla luce di due questioni tra loro opposte, ma in me strettamente interconnesse: la questione borghese — etica e religiosa — e la questione marxista. Il prodotto più recente di questo oscuro sviluppo è Il Vangelo secondo Matteo.
Alla fine degli anni Cinquanta, una stagione della cultura italiana stava giungendo al termine: il Neorealismo, inteso come scoperta della “vita quotidiana”, si esauriva; il marxismo, che ne era stato l’ispirazione e il mediatore, entrava in crisi. In quell’epoca iniziai a fare cinema, verso i trent’anni. In precedenza ero stato scrittore (romanzi, poesie e saggi). All’inizio della mia attività cinematografica, abbandonando la letteratura per il cinema, ritenevo di poter semplicemente mutare tecnica espressiva. Solo oggi mi rendo conto che, invece di abbandonare la letteratura — ossia l’uso della lingua italiana in quanto tale — non passai a una nuova tecnica, bensì a un nuovo linguaggio. Fu una nuova forma di protesta radicale contro la società italiana della piccola borghesia; ma fu anche un tentativo di ampliare l’orizzonte delle mie problematiche e di estendere il mio pubblico.
Nel realizzare un film utilizzo consapevolmente un linguaggio interclassista e internazionale, privo di tradizioni particolaristiche, salvo quelle riconducibili a una determinata scuola cinematografica (ad esempio il Neorealismo, la Nouvelle Vague, ecc.). Mentre il destino di un romanzo scritto in una lingua nazionale è legato a quello della nazione stessa — secondo un rapporto di “omologia” (cfr. L. Goldmann, Per una sociologia del romanzo) — il destino del film è in parte sottratto a tali limitazioni, poiché non si esprime in una lingua nazionale, bensì in un linguaggio comune a tutte le classi e a tutte le nazioni.
Come descriverei i miei film? Che cosa cerco di realizzare in essi? Cose, cose, all’infinito: non tutte necessarie, né pienamente comprensibili o esprimibili. Tuttavia, supponendo che questo simposio abbia carattere scientifico, dirò che finora i miei film hanno rappresentato ciò che Oscar Lewis definisce la “civiltà della povertà” (il mondo dei poveri).
D: Quali registi hanno maggiormente influito su di lei? E in che modo?
R: Chaplin (il suo universo di povertà operaia; l’assolutezza delle sue immagini; la fusione stilistica di comico e tragico); Dreyer (l’ispirazione religiosa eterodossa; l’assolutezza delle immagini); Keaton (la perfezione di The General); Renoir (la nostalgia per quel mondo borghese che non riesco ad amare; l’assolutezza e l’eleganza delle immagini); Mizoguchi (il sentimento epico, la perfezione formale assoluta e quasi ossessiva); Ichikawa (una religiosità fluida, priva di limiti se non quello che Auerbach definisce “pietà per il creato”); Bergman; Welles; Godard; Tati (l’unico e vero poeta della piccola borghesia) — e probabilmente altri che al momento non ricordo.
D: Quale qualità ritiene più necessaria in un regista?
R: Due qualità essenziali: la capacità di “riempire sempre lo schermo” (come dice il mio amico Moravia), vale a dire non cessare mai di essere visivo o visionario, così da conferire valore — anche eccedente — a ogni dettaglio della realtà che occupa ogni centimetro quadrato dell’inquadratura. La seconda qualità consiste nel conoscere profondamente gli uomini, nel saperli leggere immediatamente fino alle loro profondità interiori. L’immagine filmica di un uomo è un indizio implacabile: rivela subito e senza equivoci la vera realtà della persona rappresentata. Soprattutto un regista come me, che lavora quasi sempre con attori non professionisti “scelti dalla strada”, deve essere in grado di cogliere all’istante la verità di un volto, di una presenza, la vera realtà psicologica e morale della persona prescelta. Ciò è particolarmente difficile nel caso dei protagonisti, ma lo è altrettanto per i personaggi secondari o per le comparse (che scelgo personalmente una per una), poiché spesso il tempo a disposizione per tale selezione è di pochi giorni o addirittura di pochi minuti.
D: Quali registi dell’industria cinematografica ritiene stiano contribuendo ad affermare standard artistici più elevati nel cinema?
R: La risposta è molto semplice, e al tempo stesso ingiusta: i registi che ottengono maggiore successo.
D: Quale considera la funzione principale del film?
R: Rispondo come regista. È evidente che un filmologo, un sociologo e, naturalmente, un produttore fornirebbero tre risposte differenti. Per un regista che “fa” film come si “fa” poesia, è chiaro che la funzione del film coincide con quella della poesia. Ma qual è la funzione suprema della poesia? A questa domanda non so rispondere.
D: Ha una teoria della regia? Della recitazione cinematografica?
R: Non possiedo una teoria, bensì uno stile. In altra sede, con maggiore spazio a disposizione, potrei descrivere tale stile in termini filologici, nella misura in cui categorie filologiche possano essere applicate al cinema contemporaneo. Il mio stile trae origine da un retroterra letterario specifico; direi anzi da una tradizione particolaristica, che presenta anche alcune connotazioni etniche. In breve, sono profondamente sud-europeo. Faccio un esempio: non riesco neppure a concepire un’inquadratura in cui un personaggio sia ripreso di profilo completo o di spalle, nemmeno nel caso di un dialogo tra due persone. Nei miei film i due interlocutori sono sempre in posizione di tre quarti o frontalmente contrapposti, spesso in modo assai frontale e in primo piano. Ciò significa che la mia cultura è più figurativa che propriamente cinematografica. Il mio stile è dunque fortemente selettivo e tende a inclinare verso il versante del “sublimis” (elevato), anche se i miei personaggi e i miei paesaggi appartengono quasi sempre al mondo dell’“humilis” (umile), per non dire “piscatorius”.
Per quanto riguarda la recitazione cinematografica, tendo a utilizzare attori non professionisti. Ho sempre scelto persone che non avevano mai recitato né in teatro né al cinema. Possiedo un metodo del tutto personale — che deriva dalla selettività del mio stile — per far comportare i miei personaggi davanti alla macchina da presa. Qualora scelga un attore professionista, lo faccio per la stessa ragione per cui scelgo un non professionista: lo utilizzo per ciò che egli è, e non per ciò che potrebbe “fingere di essere” attraverso gli strumenti della sua professione.
D: È costretto a lavorare sotto vincoli commerciali? Di quale natura?
R: No. Finora tutti i miei film sono stati prodotti dallo stesso produttore, Alfredo Bini. I miei unici vincoli sono stati una naturale autocensura e una grave, spesso deprimente, scarsità di risorse finanziarie.
D: Se fosse libero da ogni vincolo, che tipo di film vorrebbe realizzare?
R: Poiché, come ho detto, il mio principale limite è di natura commerciale, vorrei — ahimè — poter realizzare un film dal costo di mezzo miliardo di lire. Oltre questo, non oso sognare.
D: A suo avviso, verso quali esiti stanno conducendo le attuali sperimentazioni dell’avanguardia?
R: Quasi sempre, almeno in Europa e in particolare in Italia, l’avanguardia si presenta come un fenomeno eminentemente formale. Essa ingaggia una dura lotta con il linguaggio, coinvolgendo solo incidentalmente i contenuti; di conseguenza, non turba né disturba realmente nessuno. Se invece per avanguardia si intende un intervento morale violento (ad esempio: l’anarchia beatnik, il movimento non violento, il teatro della crudeltà, per citare solo alcuni casi), allora ritengo che l’avanguardia potrebbe guidare una lotta giustache ogni autore conduce, scalzo e coperto di una tunica miserabile come Socrate, contro ogni forma di potere costituito.
D: Quali direzioni ritiene che il lungometraggio prenderà nei prossimi cinque o dieci anni?
R: Non saprei rispondere, neppure limitando la previsione ai miei stessi film. Posso soltanto menzionare un fenomeno che ho individuato in un mio saggio, che qui richiamo: il cinema tende, come la lingua letteraria nei suoi momenti di maturità, a suddividersi in diversi sottolinguaggi specializzati. Pertanto, così come esistono un “linguaggio della prosa” e un “linguaggio della poesia”, esistono anche un “cinema di prosa” e un “cinema di poesia”.
Il cinema di prosa va dai più comuni film commerciali fino ai film di Ford; il “cinema di poesia” comprende invece uno stile internazionale che si estende da Parigi a New York, da Praga a Brasilia (cito due esempi: Prima della rivoluzione di B. Bertolucci e, naturalmente, tutti i film di Godard).
La mia distinzione non riguarda il valore, bensì la tecnica. Naturalmente possono esistere film realizzati secondo il canone del “cinema di poesia” che siano del tutto privi di poesia. Anche il pubblico comincia a differenziarsi: così come i libri di poesia si rivolgono a un pubblico più selezionato, i “film di poesia” raggiungono il pubblico attraverso il circuito ristretto del “saggio cinematografico”. Due tecniche differenti, dunque, e due distinti canali di distribuzione.
D: Quale potrebbe essere, a suo avviso, l’aspetto più sorprendente o inusuale dei film del futuro?
R: Una distinzione sempre più profonda tra “cinema di prosa” e “cinema di poesia”. Oggi il cinema non è ancora realmente differenziato. Una maggiore articolazione stilistico-linguistica consentirà la formazione di una vera e propria “civiltà del cinema”.
D: Altro?
R: Cos’altro? Ciò che per me è più importante in questo momento: lo sviluppo di un linguaggio della forma filmica. Il cinema è una lingua o un modo di espressione?
Così pone la questione Christian Metz. Quanto a me, sarei incline a ritenere che il cinema, nell’ambito della linguistica saussuriana — e in parte anche in opposizione a essa — possa essere definito senza dubbio come una “langue” insieme ipotetica e attuale. Naturalmente, in tal caso, l’idea stessa di “langue” dovrebbe essere ampliata (allo stesso modo in cui la cibernetica ci ha costretti ad ampliare il concetto di “vita”).
È dunque necessario elaborare una semiologia del cinema come modo di espressione. È altresì necessario avviare una definizione morfologica del cinema in quanto linguaggio. (A questo punto non posso che rinviare il lettore americano, per quanto mi riguarda, ai «Cahiers du Cinéma», n. 171, ottobre 1965, e, per quanto concerne Christian Metz, alla rivista «Communications», n. 4. Ma il dibattito è soltanto agli inizi.)
P.P. PASOLINI, Pier Paolo Pasolini: intervista, in Film director on film, su «Arts in society», Volume 4, Issue 1 Winter 1966-67, pp. 72-76. Traduzione Silvia Martín Gutiérrez.
Students of film history and film theory at the University of Wisconsin who assisted in the compilation of this symposium are Seyna Jo Bruskin, Peter Reiner, Dick Swaback, John Walker, and Karen Weiskopf. Copyright, 1966, by the Regents of the University of Wisconsin.



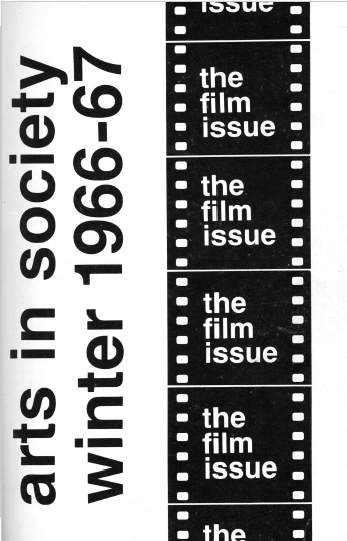



Commenti